Nel contesto dell’apprendimento universitario, uno degli aspetti ancora troppo sottovalutati riguarda il ruolo degli stili cognitivi. Spesso si dà per scontato che tutti gli studenti apprendano allo stesso modo, ma la realtà è ben diversa: ognuno di noi ha una propria modalità di elaborare le informazioni, di concentrarsi, di risolvere problemi e di organizzare le conoscenze. Queste differenze individuali non sono semplici curiosità psicologiche, ma elementi centrali che possono influenzare in modo significativo la riuscita accademica.
Conoscere il proprio stile cognitivo — e quello dei propri studenti, nel caso dei docenti — permette di adattare le strategie di studio e di insegnamento, rendendole più personalizzate, efficaci e motivanti. In un’università che ambisce a essere sempre più inclusiva e attenta ai bisogni reali degli studenti, integrare la consapevolezza degli stili cognitivi può rappresentare un importante passo avanti verso un apprendimento personalizzato, capace di valorizzare il potenziale di ciascuno. La didattica, quindi, non può più limitarsi a trasmettere contenuti in modo uniforme, ma dovrebbe tenere conto della varietà dei profili cognitivi presenti in aula o online.
Cosa sono gli stili cognitivi?
Gli stili cognitivi sono le modalità preferenziali con cui una persona percepisce, interpreta, organizza ed elabora le informazioni provenienti dal mondo esterno. A differenza del quoziente intellettivo o delle competenze specifiche, che misurano quanto una persona sa o sa fare, lo stile cognitivo descrive come quella persona tende ad affrontare i compiti cognitivi. In altre parole, è una lente attraverso cui ciascuno guarda e struttura la realtà. Alcuni studenti, ad esempio, preferiscono un approccio analitico, procedendo passo dopo passo e curando ogni dettaglio, mentre altri adottano una visione più globale, cogliendo prima il quadro d’insieme e poi i particolari.
Queste preferenze non sono giuste o sbagliate, migliori o peggiori: sono semplicemente diverse. E comprendere questa diversità è fondamentale nell’ambiente universitario, dove la mole di contenuti da apprendere, la varietà dei metodi didattici e l’autonomia richiesta agli studenti possono mettere a dura prova anche i più motivati. Avere consapevolezza del proprio stile cognitivo consente di orientarsi meglio tra i metodi di studio, scegliere gli strumenti giusti (mappe concettuali, schemi, audiolezioni, esercizi pratici, ecc.) e persino gestire meglio il tempo e le energie mentali. In questo senso, gli stili cognitivi diventano una vera e propria bussola per lo studio universitario, capace di guidare scelte più consapevoli e produttive.
Classificazioni degli stili cognitivi
Nel corso degli anni, numerosi studiosi hanno cercato di classificare gli stili cognitivi per comprenderne meglio il funzionamento e le ricadute sull'apprendimento. Le classificazioni più note si basano su contrapposizioni che descrivono le preferenze mentali degli individui. Una delle più utilizzate è quella che distingue tra stile analitico e stile globale: il primo predilige un approccio sequenziale, logico e focalizzato sui dettagli; il secondo, invece, tende a cogliere la visione d’insieme, cercando collegamenti tra concetti apparentemente distanti.
Un’altra distinzione molto diffusa è quella tra stile verbale e stile visivo. Chi ha uno stile verbale apprende più facilmente attraverso la lettura o l’ascolto di spiegazioni, mentre chi ha uno stile visivo preferisce diagrammi, mappe e rappresentazioni grafiche. A queste si aggiungono altre dimensioni, come il campo dipendente vs campo indipendente (ovvero la tendenza a essere influenzati o meno dal contesto), lo stile riflessivo vs impulsivo, e persino modelli più strutturati come il modello esperienziale di Kolb o quello di Felder e Silverman, molto usato in ambito STEM.
Tutte queste classificazioni hanno in comune un punto: gli studenti non sono tutti uguali e, di conseguenza, non dovrebbero essere trattati come se lo fossero. Comprendere in quale punto dello spettro cognitivo ci si colloca, o collocano i propri studenti, aiuta a creare ambienti educativi più efficaci e inclusivi.
Implicazioni per l’apprendimento universitario
L’università è il luogo per eccellenza in cui lo studente è chiamato a diventare protagonista del proprio sapere. Tuttavia, questo processo è tutt’altro che lineare, soprattutto se non si conosce il proprio modo preferenziale di imparare. È qui che entrano in gioco gli stili cognitivi, con tutte le loro implicazioni sul piano della didattica, della motivazione e delle strategie di studio.
Uno studente con stile visivo, ad esempio, potrebbe trovarsi in difficoltà in corsi dove prevale la spiegazione orale o la lettura di lunghi testi, mentre eccellerebbe in ambienti dove vengono usate presentazioni grafiche, schemi o mappe concettuali. Al contrario, uno studente con stile verbale potrebbe apprendere poco da immagini e video, ma troverebbe grande beneficio nell’ascolto di podcast o nel prendere appunti dettagliati. Questa consapevolezza può trasformare il modo in cui si affrontano le sessioni di studio, rendendole non solo più produttive, ma anche meno stressanti.
Dal punto di vista dei docenti, invece, riconoscere la diversità cognitiva tra gli studenti consente di strutturare lezioni più accessibili, variegate e stimolanti, integrando linguaggi diversi e modalità multiple per trasmettere gli stessi contenuti. In un momento storico in cui l’università si confronta con temi come la dispersione, il benessere studentesco e l’inclusività, integrare la conoscenza degli stili cognitivi nella didattica non è un lusso, ma una necessità.
Apprendimento personalizzato e didattica inclusiva
Il concetto di apprendimento personalizzato sta guadagnando sempre più centralità nel dibattito educativo, soprattutto in ambito universitario, dove l’eterogeneità degli studenti è evidente non solo a livello culturale e sociale, ma anche cognitivo. Integrare gli stili cognitivi nella progettazione didattica significa offrire a ogni studente l’opportunità di imparare nel modo che più si adatta al proprio funzionamento mentale. Questo approccio, lungi dall’essere un’utopia, rappresenta una concreta possibilità per rendere l’università più inclusiva, accessibile ed efficace.
Adottare una didattica inclusiva basata sulla varietà degli stili cognitivi significa strutturare i contenuti in modo flessibile: alternare momenti visivi e verbali, dare spazio sia alla riflessione individuale sia alla sperimentazione pratica, utilizzare mappe, infografiche, podcast, quiz interattivi, schemi e narrazioni. La tecnologia educativa offre oggi strumenti potenti per adattare i percorsi di apprendimento: dalle piattaforme di e-learning personalizzabili agli strumenti di supporto visivo, dalle app per la produttività agli ambienti virtuali di simulazione. In questo scenario, l’educazione universitaria non può più essere pensata come un’unica strada da percorrere, ma come una rete di sentieri paralleli capaci di condurre ciascuno al proprio traguardo.
Strategie per studenti e docenti
Per trarre il massimo beneficio dalla consapevolezza degli stili cognitivi, è fondamentale che sia gli studenti sia i docenti adottino strategie pratiche e mirate. Gli studenti, in particolare, possono cominciare con un semplice esercizio di auto-osservazione: in quali situazioni studio meglio? Quali materiali mi aiutano di più? Quando mi sento più concentrato? Da lì, è possibile costruire una vera e propria routine personalizzata, scegliendo strumenti e tecniche coerenti con il proprio stile: chi ha uno stile globale può partire da mappe concettuali o sintesi visive, mentre chi ha uno stile analitico potrebbe preferire prendere appunti lineari e suddividere il materiale in micro-obiettivi.
Anche i docenti universitari hanno un ruolo cruciale in questo processo. Una didattica che tiene conto degli stili cognitivi non significa semplificare i contenuti, ma moltiplicare le vie di accesso alle conoscenze. Questo può avvenire attraverso la progettazione di materiali multicanale, l’uso di linguaggi diversi nella spiegazione dello stesso concetto, l’alternanza tra attività individuali e collaborative. Inoltre, è utile fornire occasioni di autovalutazione e metacognizione, aiutando gli studenti a prendere coscienza del proprio stile e a riflettere sul proprio modo di imparare.
In questo modo, si crea un circolo virtuoso in cui lo studente diventa soggetto attivo del proprio apprendimento e il docente un facilitatore consapevole, capace di sostenere la diversità e di trasformarla in risorsa.
Da sapere
Gli stili cognitivi non sono etichette rigide, né devono essere usati per classificare o limitare il potenziale degli studenti. Al contrario, rappresentano una lente preziosa per leggere e interpretare le differenze individuali che esistono all’interno di ogni gruppo universitario. In un mondo accademico sempre più complesso e multidisciplinare, in cui si chiede agli studenti autonomia, spirito critico e capacità di adattamento, comprendere il proprio modo di apprendere diventa una risorsa fondamentale.
Saper riconoscere il proprio stile cognitivo – o quello dei propri studenti – non solo aiuta a migliorare le performance accademiche, ma contribuisce anche al benessere personale, alla gestione del tempo e alla costruzione di un metodo di studio sostenibile nel lungo periodo. L’università del futuro non può prescindere da una didattica che valorizzi le differenze e offra percorsi di apprendimento più flessibili, consapevoli e inclusivi.Se sei uno studente universitario e hai la sensazione che il tuo metodo di studio “non funzioni”, forse non sei tu a sbagliare: forse stai semplicemente usando strategie che non si adattano al tuo stile cognitivo. Prova a riflettere su come apprendi meglio: ti aiutano le immagini? I riassunti? Le spiegazioni orali? I video? Le mappe concettuali? Inizia da lì. Esplora, sperimenta, osservati. E ricordati: capire come studi è il primo passo per studiare meglio.
E se vuoi una mano ne capirlo e nel farti supportare...chi meglio di noi, che ci siamo passati prima di te?


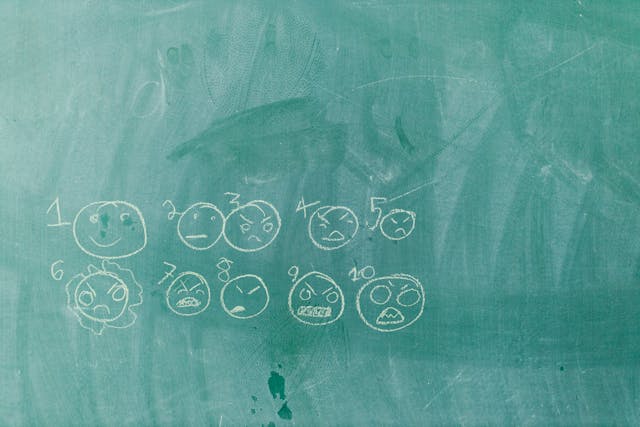
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.